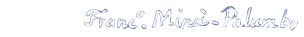La scoperta effettuata nell’ottobre del 2013 dai ricercatori del CNR di Bari della presenza del batterio denominato Xilella fastidiosa negli alberi di olivo del Salento ha avuto come conseguenza l’adozione di drastici provvedimenti dell’Unione europea e del governo nazionale prescrittivi, tra l’altro, dell’estirpazione di migliaia di piante infette anche secolari. Esattamente come accaduto un secolo e mezzo fa quando la viticoltura europea venne colpita dalla Phylloxera vastatrix e la prima risposta fu quella del taglio dei ceppi e del fuoco purificatore, si è ripercorso un sentiero che si sta trasformando in un vicolo cieco. Ieri come oggi la soluzione passa dalla scoperta di varietà resistenti e da ibridazioni in grado di potenziare le difese della pianta per renderla inattaccabile all’agente patogeno (ieri il parassita fillosserico, oggi il batterio importato dal Sud America). L’illusione dell’efficacia dei fitofarmaci e delle eradicazioni regge alcuni mesi nella fase emergenziale, poi la progressione dell’infestazione costringe a tornare nei laboratori e a ripensare le strategie, specie quando il batterio mostra un’elevata variabilità genetica e fenotipica come nel caso della Xilella.
Questa pagina infausta dell’olivicoltura pugliese richiama inevitabilmente il vivace dibattito del passato sulle modalità di approccio al ricorrente problema della resistenza delle piante alle periodiche e cangianti aggressioni patogene. Appaiono, perciò, illuminanti le riflessioni scientifiche di uno dei naturalisti siciliani dell’800 maggiormente attivi e prolifici, che dalla sua postazione periferica – pur vivendo ed esercitando la professione di medico-chirurgo a Castelbuono, piccolo centro delle Madonie – riusciva ad aggiornarsi e a mantenersi in collegamento con gli studiosi più autorevoli del suo tempo, fornendo un contributo di analisi e di sperimentazione diretta davvero invidiabile.
Nel 1853, a 39 anni, pubblicava nel «Giornale della Commissione di Agricoltura e Pastorizia», che si editava a Palermo, un saggio dal quale si rileva come avesse già recepito e applicato ai vitigni del suo territorio il sistema classificatorio innovativo creato nel 1846 dal naturalista praghese Friedrich August Rudolph Kolenati, essendo venuto in possesso di un suo scritto nella traduzione dal tedesco a cura del botanico napoletano Michele Tenore. Nella ricca bibliografia di Minà Palumbo, costituita in larga parte da diverse centinaia di articoli su periodici e riviste specializzate, non sono numerosi quelli dedicati al tema della Philloxera vastatrix, tuttavia, rivelano la sua immediata percezione del pericolo incombente.
In Italia, l’allarme era stato lanciato nel 1870 dalla «Rivista di Agricoltura, Industria e Commercio» di Firenze, con la notizia dell’avvenuta infestazione delle viti francesi e con le informazioni allora disponibili sul comportamento del parassita. A novembre dello stesso anno il medico castelbuonese mostrava di essere già ben informato e documentato, come rivela la sua prima breve corrispondenza sull’argomento, inviata al direttore del bollettino del Comizio agrario di Noto. E quando ancora in Italia molti si illudevano che la fillossera non avrebbe varcato le Alpi, lui scriveva – nel 1874 – di resistenza delle viti americane e indicava una possibile soluzione al male con il quale presto o tardi ci si sarebbe dovuti confrontare.
In una corrispondenza da Castelbuono datata 21 aprile 1880, pubblicata in «L’Agricoltura Italiana», dell’Istituto agrario dell’Università di Pisa, riferiva del primo focolaio di infezione scoperto in Sicilia nel territorio di Riesi, manifestando la convinzione dell’avvenuta diffusione in altre zone non ancora individuate.
Concreto e pragmatico, proponeva di accordare premi e incoraggiare gli studi sulla biologia dell’insetto, lasciando liberi i proprietari di introdurre vitigni resistenti al parassita. Sul terreno della divulgazione si rivelò molto impegnato compilando, nel 1881, per il periodico dell’Istituto pisano, una rassegna sull’argomento di 265 titoli, tra monografie e articoli di riviste, pubblicati in Italia dal 1868 al 1880. Quando finalmente ci si rese conto dell’inutilità del sistema distruttivo regolato dalla legge e si cominciò ad investire sulla creazione di piante resistenti mediante incroci tra varietà americane e autoctone, Minà Palumbo diede il suo contributo pionieristico.
Le sue indicazioni erano ispirate a concretezza e prudenza; ogni esperimento andava ponderato e verificato ripetutamente, nella consapevolezza che non esistesse la soluzione universale applicabile a tutti i terreni e che la compatibilità tra piede americano e vitigno locale da innestare sarebbe stata trovata solo dopo innumerevoli prove.
I suoi interventi sulla stampa specializzata erano sempre improntati alla necessità di svolgere una funzione didattica nei confronti dei viticoltori che in larga parte affrontavano la ricostituzione dei propri vigneti con approssimazione e persino scarsa competenza, come ebbe a lamentare nelle pagine del periodico del Comizio agrario palermitano, nel 1891, offrendo una selezione ragionata delle principali caratteristiche di alcune varietà americane. Non visse tanto da assistere al pieno successo delle sue intuizioni sulla validità della tutela delle biodiversità e della sperimentazione agronomica, ma i risultati conseguiti nel primo ‘900 si devono anche alla sua visione moderna della botanica. Una nuova generazione di viticoltori avrebbe raggiunto il traguardo.
Articolo tratto da www.lidentitadiclio.com